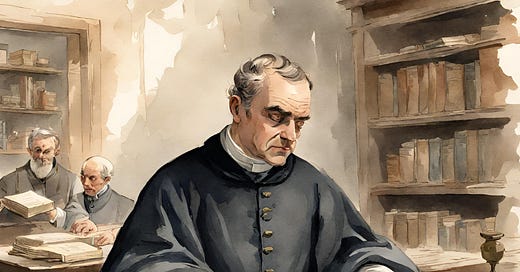Lezioni di censura n.2 | Il ruolo della Chiesa
Censura preventiva e repressiva sono due facce della stessa medaglia, mentre la vera lotta per il controllo delle idee si gioca tra censura ecclesiastica e censura civile.
(Un censore ecclesiastico a inizio Ottocento mentre rilegge uno scritto “aggiustandolo” perché rispetti i canoni della censura. Immagine creata da Ai di Canva)
Questa è la seconda puntata di Lezioni di Censura, l’edizione speciale della newsletter dedicata alla storia della censura attraverso 100 anni di regole, scontri e lotte di potere. Puoi recuperare il primo numero qui. E dato che anche questo pezzo è lungo (non è vero, è per via delle note) aprilo direttamente sul tuo browser o la mail verrà troncata. Per la serie: #maiunagioia
Nelle puntate precedenti…
Italia, 1848. Alla vigilia dei moti che apriranno la strada alle riforme e all’Unità del paese tredici anni più tardi, un tentennante Re Carlo Alberto di Savoia, sovrano del Regno di Sardegna, concede finalmente ai suoi sudditi una monarchia costituzionale.
E’ una cosa che anche altri regnanti in giro per la penisola stanno facendo perché la gente non ne può più di non contare nulla nella gestione della “cosa pubblica”. Proteste e rivolte sono all’ordine del giorno già da diversi anni.
Questa nuova forma di governo prevede che i sudditi non siano più sudditi ma cittadini, con libertà riconosciute, e che il re coabiti con un organo parlamentare.
Tra le libertà concesse, Carlo fa riconoscere la libertà di stampa da cui sembra essere ossessionato perché teme quello che possono dire i giornali di lui, della gestione della monarchia. Teme che il piano di concedere un regime costituzionale “reversibile”, cioè fantoccio, venga scoperto. Per questo appena poche settimane dopo la firma dello Statuto Albertino, come primo atto del suo governo fa emanare una legge speciale sulla stampa che “ne reprime gli abusi”.
E’ un documento importante perché sarà poi esteso all’Italia dopo l’unificazione. Ed è importante perché segna il passaggio ufficiale dalla censura preventiva a quella repressiva.
Ancora oggi nella nostra Costituzione vive un sistema di censura repressiva, perché non esistono e non sono mai esistite una libertà di stampa e una libertà d’espressione assolute, sciolte da vincoli.
Per capire la portata di questo spartiacque vi racconto come funzionava la censura prima del 1848 e come Chiesa e Re si sono fatti la guerra per il controllo di libri, stampa, circolazione di idee.
Quinto potere
La bibliografia storica non considera la censura sempre e solo un male. Sin dal XVI secolo, questo meccanismo è uno strumento di controllo del potere e delle idee e, in ogni caso, è sempre considerato come un necessario complemento della diffusione del pensiero e della conoscenza1.
Nel primo numero di Lezioni di censura abbiamo visto quanto tempo avesse occupato nei dibatti del Consiglio di Conferenza l’elaborazione di un sistema di controllo della stampa periodica che non fosse inconciliabile con il riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini2.
Il tema della libertà di manifestazione del pensiero, di cui la libertà di stampa rappresenta una specificazione3, è indissolubilmente legato alla censura. Libertà e limite vanno di pari passo sin dalla diffusione dei testi a stampa – e anche prima, se per censura intendiamo la capacità di combattere l’opinione altrui4.
Ma in Italia, questa coabitazione è così raffinata da meritare un’analisi a sé.
Censura preventiva e censura repressiva
Prima dell’editto di Carlo Alberto, più o meno in tutti i regni italiani la censura era solo preventiva ed era regolata all’incirca stesso modo, invece dopo l’editto sulla stampa di Carlo, nel Regno di Sardegna si passa in modo netto alla censura repressiva.
Questo vuole dire che per un periodo più o meno lungo tredici anni, prima cioè che la censura repressiva diventi lo standard in tutto il territorio italiano, nella penisola coesistono entrambi questi sistemi.
Vincenzo Gioberti lo spiega sicuramente meglio di me quando dice che “due sorti di censura si trovano; l’una preventiva, che versa sugli scritti prima che escano alla luce; l’altra repressiva, che viene appresso, ed esercita la sua giurisdizione sull’autore del libro e su coloro che lo divulgano”5.
Nel primo caso cioè l’oggetto del controllo è lo scritto, sono le idee. Una legge deve stabilire a priori quali siano i temi proibiti, i casi in cui un testo non possa essere validato. Bisogna mettere in piedi centri di revisione che devono dare autorizzazioni o dinieghi. I censori possono interpolare, manipolare e modificare un testo prima della sua pubblicazione pur di renderlo conforme alle norme.
E’ sicuramente un sistema più burocratico, che prevede procedure amministrative molto invadenti.
Anche nel sistema repressivo c’è una legge che deve dire quando un contenuto è vietato, ma non può bloccarne la stampa. Quindi l’oggetto del controllo si sposta, dallo scritto al suo autore. Al massimo si interviene sulla diffusione di un libro o stampato.
Nel sistema repressivo ognuno è libero di stampare quello che vuole, ma se il tema viola la legge il testo può essere sequestrato, distrutto, e l’autore, lo stampatore e il gerente responsabile della pubblicazione possono subire serie conseguenze. Anche penali.
Sintetizzando: nel sistema preventivo servono autorizzazioni amministrative, ci sono delle sanzioni da pagare e tutto il controllo è sviluppato prima del visto-si-stampi. Se una pubblicazione non è autorizzata, è clandestina e perseguibile.
Nel sistema repressivo, invece, tutto il controllo è spostato a valle, il che richiede potenziare il sistema penale e di polizia, strutturandolo bene per punire i trasgressori.
Ci sono, in entrambi questi meccanismi, poteri, diritti e limiti ben definiti6. Eppure non è così scontata questa suddivisione. In altri ordinamenti europei dell’epoca il confine tra i due meccanismi di censura non era così netto. Ad esempio nell’ordinamento prussiano la mescolanza di misure preventive e repressive è tale da riuscire difficilmente distinguibili le une dalle altre7.
La censura ecclesiastica
Che cosa vuol dire questo? Che in Italia c’è sempre stata una grande lucidità nella spartizione di questi due tipi di controllo, non tanto per abilità politica e giuridica nel regolare il fenomeno8, quanto nell’esistenza di un precedente storico ben radicato nella penisola.
Stiamo parlando della secolare esperienza in materia di censura maturata dalla Chiesa di Roma, prima in risposta agli attacchi del luteranesimo, poi all’interno dei Tribunali della Santa Inquisizione, per arginare la diffusione di principi eretici o solo anti-clericali.
Insomma, preti e papi hanno sempre avuto qualcosa da insegnare ai regnanti civili in materia di censura preventiva - campo in cui hanno sempre spadroneggiato, come emerge dalle bolle papali e dai resoconti dei censori9 all’interno degli Stati Romani. E’ naturale che essendo già ben regolata da centinaia di anni, questa forma di censura fosse anche quella più diffusa.
Anzi, prima del 1848 la sola censura efficace era e restava quella che usava regole messe a punto dalla Chiesa.
Negli Stati Romani il metodo di revisione di testi e giornali poteva contare su una prassi da tempo consolidata e, grazie agli editti papali, i criteri a cui i censori dovevano rifarsi erano costantemente aggiornati (tanto che molti di questi editti sono la base normativa della censura in diversi Regni italiani10).
Merito appunto di tanta pratica sul campo. Per dare un’idea, durante la prima metà del Settecento è la Curia papale a occuparsi dell’applicazione dei criteri censorii.
Al vertice dell’organo di controllo è preposto il “Maestro del Sacro Palazzo”. Questa figura nasce nel 1218 con funzioni di assistenza spirituale ai residenti del Palazzo Apostolico ma poi, con lo sviluppo della stampa e l’intensificazione delle relazioni culturali, verrà investita dai diversi pontefici di un compito dalla portata molto più estesa: regolare tutta l’attività di stampa e tutta la circolazione libraria a Roma e in Comarca (la delegazione amministrativa dello Stato Pontificio che includeva Roma e l’attuale Agro Romano).
Nel 1728, ad esempio, Maestro del Sacro Palazzo Apostolico è Benedetto Zuanelli, dell’Ordine dei Padri Predicatori, responsabile sia della revisione della stampa e dei libri pubblicati a Roma che dell’intero commercio librario della capitale pontificia. “Nei fatti non solo era demandata al Maestro la concessione dell’Imprimatur per ogni singola stampa pubblicata, ma questi gestiva anche il rilascio delle patenti e il controllo sull’attività degli stampatori e dei librai11”. Insomma, un enorme potere concentrato nelle mani di un emissario papale.
Censura civile ed ecclesiastica, una coabitazione a orologeria
L’importanza e il peso della censura ecclesiastica è quindi cruciale per il dibattito sul costituzionalismo moderato piemontese e, di riflesso, italiano. Controllare la stampa, significava controllare anche la politiche di un territorio e il papato, rispetto a un Re Carlo, poteva esercitare questo potere anche al di là dei confini del suo regno.
Cosa che durante gli anni tumultuosi dell’Ottocento aveva fatto gioco ai reali: chi, meglio della Chiesa, poteva castrare forme di protesta sobillate per iscritto? Cassare idee “pericolose” o troppo lontane dallo status quo?
Epperò a ognuno il suo: mentre la Chiesa poteva avere sempre l’ultima parola su testi prodotti e pubblicati anche oltre i confini dei suoi territori, alla vigila del ‘48 non valeva affatto il contrario per i governanti civili. Il che richiama il secolare braccio ferro tra potere temporale e potere spirituale che, proprio negli anni Quaranta dell’Ottocento, rischia di rinfiammarsi.
Accanto al sistema preventivo/repressivo dobbiamo quindi aggiungere la distinzione tra censura ecclesiastica e censura civile. Nel Regno di Sardegna, nella Torino di Re Carlo, coesistono, in modo forzato, centri di controllo della stampa che rispondono ai vicari papali da un lato e centri di controllo governati dai ministri laici dall’altro.
Ma con l’avvento del regime costituzionale, è tempo per l’ordinamento civile di riprendersi il potere completo.
L’editto sulla libertà di stampa del ’48 prevede infatti l’estensione del controllo “laico” anche sui manoscritti dei Vescovi, cosa che innescherà forti polemiche e rimostranze documentate negli atti del Consiglio di Conferenza.
La macchina della censura ecclesiastica
Poiché era uno strumento di indirizzo e gestione dell’ordine pubblico12, il diritto di censurare veniva rivendicato tanto dai sovrani statali, quanto dalle Università e soprattutto dalla Curia romana13.
Il nihil obstat ecclesiastico era cruciale per una pubblicazione, solo che il processo per ottenerlo richiedeva rispetto di criteri molto stringenti. Ecco perché, contestualizzato, l’editto sulla stampa di Re Carlo appare invece molto innovativo e liberale sia per l’epoca sia rispetto alla censura religiosa14.
Certo, chi pubblicava opere in quel periodo doveva avere un bel mal di testa, perché magari uno scritto poteva passare il controllo civile ma non quello ecclesiastico. Piccolo ripassino: il quadro geopolitico della penisola è quanto mai variegato alla vigilia del 1848 e, in assenza di un ordinamento giuridico omogeneo, libertà di stampa e censura costituiscono oggetto di regolamentazioni diverse, sottoposte a criteri applicativi differenti da regno a regno15.
Ma la macchina della censura dello Stato Pontificio non ha eguali e opera in modo estremamente capillare e con lo stesso metodo, a prescindere dai confini territoriali.
La Chiesa è tra i primi governi a istituire nel 184716 dei veri e propri Consigli deputati all’esame (preventivo alla pubblicazione) di qualunque testo a contenuto o richiamo religioso e politico17.
Sulla base di un editto promulgato da Papa Leone XII nel 1825, infatti, alla censura preventiva ecclesiastica competevano non solo i contenuti scientifici, morali e religiosi degli scritti, ma anche quelli politici18.
Rispetto alla censura civile, poi, la censura ecclesiastica gode di un’articolazione strutturale molto più complessa e diramata grazie alla presenza di censori vicari in tutti i capoluoghi di provincia e nei comuni minori italiani, anche al di là dei confini papali. Insomma, ha risorse che un regno ordinario non può permettersi.
Certo, il sistema non sempre è efficiente. Se ne lamenta un pochino, nel preambolo all’editto papale sulla stampa firmato da Pio IX nel 1847, il Segretario di Stato Cardinal Gizzi quando critica la lentezza e l’elusività dell’attività di revisione da parte “di quei soli Censori a cui [la censura] era stata d’apprincipio raccomandata”19, sia nella provincia romana che nel resto della penisola.
In base a quanto stabilito dalla vecchia legge del 1825, quindi, ogni provincia aveva un unico censore ecclesiastico, un vero e proprio organo monocratico, il cui giudizio era inappellabile, senza però “un codice davanti agli occhi col quale confrontare lo scritto” – così il Cardinal Gizzi. Capito? Il censore doveva decidere a suo gusto e senza criteri oggettivi e la sua decisione era definitiva, e Gizzi pensava che questa fosse una sonora stupidaggine.
In realtà, ciò di cui il Cardinale si lamenta non è una vera e propria assenza di regole in materia di censura – queste si fondavano sul procedimento utilizzato dal Sant’Uffizio per l’iscrizione dei testi nell’Indice dei libri proibiti – ma della loro disomogeneità, sia in termini di procedura che di merito.
Il ruolo dell’Inquisizione: gli organi della Chiesa per censurare i testi
Il controllo dei testi rientrava nella normale politica di ordine pubblico adottata dalla Santa Sede20 che lo esercitava attraverso due organi: il Sant’Uffizio e la Congregazione dell’Indice.
Mentre il primo esercitava la censura come strumento complementare al più generale controllo inquisitorio, il secondo doveva occuparsi della compilazione periodica dell’Indice per sbarazzarsi dei libri e dei testi non graditi.
Anche la Congregazione però aveva sempre operato sulla base di prassi, non di regole uniformi. Bisognerà aspettare Papa Benedetto XIV e il 1753 per le prime norme scritte. Il Supremo Tribunale religioso considerava la censura libraria come una appendice dei più gravosi esami sulle questioni di fede e di morale. Di fatto, fino al XIX secolo non esistono leggi organiche che disciplinino il procedimento di censura o i criteri da adottare per l’esame di merito21.
Denunce e lettere di delazione
Dalle relazioni dei censori e dai documenti ufficiali della Curia, però, emerge abbastanza chiaramente quale fosse la prassi seguita dagli revisori ecclesiastici. Il controllo doveva essere sollecitato dalla denuncia dell’opera o dell’articolo attraverso una “lettera di delazione”.
Competente a presentarla era chiunque fosse capace di leggere e scrivere, oltreché di fede cattolica. La denuncia poteva essere indirizzata indistintamente o all’intera Curia papale – di cui Sant’Uffizio e Congregazione erano componenti – o all’uno dei due organi. Anche il Papa, in quanto giudice supremo dell’Inquisizione, avrebbe potuto essere destinatario in prima persona di una segnalazione.
Dato lo scopo specifico per cui era stata creata, alla Congregazione venivano indirizzate la maggior parte delle denunce, anche quelle presentate al Sant’Uffizio il quale raramente si occupava di censura libraria e rimetteva, pertanto, quasi tutte le questioni ai compilatori dell’Indice.
In ogni caso, prima di passare al vero e proprio esame dei testi, i due organi dovevano nominare due consultori ciascuno, perché svolgessero una valutazione preliminare per accettare o respingere l’eventuale prosecuzione del procedimento (una sorta di rinvio a giudizio dei giorni nostri).
In caso di esito negativo, tutto cadeva. Ma se la segnalazione fosse stata effettuata dal Papa in persona o da un’altra personalità della Curia era da intendersi che il procedimento doveva continuare, a prescindere da una eventuale valutazione negativa dei consultori.
Nella rara eventualità che questo dovesse proseguire in seno al Tribunale dell’Inquisizione, la censura vera e propria veniva rimessa a un perito nominato dal Papa, oppure due nel caso “l’opera inquisita appartenesse a un cattolico di fama irreprensibile”22.
In questo modo, nel corso del XIX secolo la Santa Sede riuscì a creare intorno a sé una schiera di esperti teologi, filosofi e giuristi – principalmente ecclesiastici, ma le successive riforme avrebbero aperto anche a personalità colte del mondo laico – cui attingere per le nomine.
Il Sant’Uffizio poteva pescare da un gruppo stabile di collaboratori, detti qualificatori, reperibili in qualunque momento dai cardinali dell’Inquisizione per poter eseguire un esame censorio.
Tanto l’esame sostanziale quanto il giudizio finale erano rimessi a un solo qualificatore per volta, il che rende il procedimento censorio dell’Inquisizione un procedimento a carattere monocratico e privo di un secondo grado.
Quando invece era la Congregazione dell’Indice a dover eseguire il controllo, i due consultori riuniti in collegio dovevano presentare una relazione ai cardinali della Curia con quattro possibili esiti: la negazione diretta dell’imprimatur – attraverso il prohibeatur –, il differimento del caso – la dilata –, la necessità di redigere un’ulteriore e più accurata relazione sul testo – scribat aliter – oppure l’assoluzione.
Se il dibattito dei consultori non trovava soluzione unanime, venivano annotati i voti di minoranza e di maggioranza e presentate relazioni al riguardo e solo in seguito al raggiungimento di un accordo il caso sarebbe passato alla decisione dei cardinali della Congregazione.
Anche se l’esame preliminare aveva una funzione puramente indicativa, dal momento che la decisione sui quattro possibili esiti era rimessa in ultima analisi ai cardinali, questo procedimento concedeva comunque qualche garanzia in più rispetto all’esame monocratico.
Questo era quello che accadeva a Roma. Invece, a livello locale e provinciale, per l’esame censorio c’era un censore vicario, nominato dal Papa, e spesso coincidente con il responsabile ecclesiastico di una biblioteca (sempre che ci fosse una biblioteca).
In questo caso, l’analisi poteva restare nelle sue mani, oppure essere spedita a Roma, ma non esisteva un obbligo – obbligo che più tardi verrà introdotto da Leone XII per i manoscritti “politici”.
Sino agli inizi dell’Ottocento questo processo di smistamento e analisi dei testi da parte di consultori, periti, qualificatori e censori vicari è guidato da regole consuetudinarie destinate a essere accorpate e riformate solo nel 1815, grazie a una serie di istruzioni che renderanno obbligatori, per tutti gli uffici censorii, i principi contenuti nella bolla Sollicita ac provvida introdotta da Benedetto XIV nel 1753.
Censura ecclesiastica e scritti politici
Ma è con l’editto di Leone XII nel 1825 che la censura fa un salto di qualità stabilendo quali sono le materie, i temi, su cui la Chiesa può esercitare, in alcuni casi accentrare, il suo controllo a prescindere dai confini territoriali.
L’editto leonino rimette la censura scientifica, morale e religiosa al pieno arbitrio del singolo revisore – o perito nel caso del Sant’Uffizio o cardinale nel caso della Congregazione –, ma prevede anche un procedimento diversificato per la censura politica esercitata nelle province e nelle sedi distaccate della Santa Sede.
Il titolo I, paragrafo 8, infatti, disponeva che laddove “le scritture da mettersi a stampa [potessero] dar cagione di lamento agli esteri Governi, o suscitare nello Stato pericolose controversie”, il censore avrebbe dovuto inviare una specifica richiesta di pubblicazione direttamente alla Segreteria di Stato papale – elevata a Supremo Consiglio di Censura – concentrando in essa il vero esame sostanziale e tramutando ben presto il controllo dei censori vicari in un mero controllo formale.
La responsabilità di concedere l’imprimatur per un’opera o un articolo a contenuto politico, infatti, era divenuta troppo grande per poter essere lasciata alla volontà dei singoli controllori ecclesiastici – specialmente di coloro che esercitavano lontano da San Pietro – i quali, timorosi di ritorsioni da parte di Roma, iniziarono a cassare drasticamente le pubblicazioni oppure, ed è il caso più frequente, a passarle direttamente al Consiglio di Censura centrale non appena ravvisassero riferimenti politici, diretti o indiretti.
E poiché la maggior parte degli scritti del periodo trattava temi attuali e difficilmente scindibili dalla politica, ben presto Roma si trovò ingolfata di richieste di pubblicazione.
Nell’ambito della censura preventiva di questo periodo la Segreteria di Stato vaticana non può essere considerata un secondo grado di giudizio. Non avrebbe in alcun modo riverificato l’esame condotto da un censore di un’altra provincia su uno scritto politico e, grazie all’editto di Leone XII, finì con il reiterare l’arbitrarietà e l’iniquità proprie del censore monocratico locale.
Inoltre, la costituzione di un unico Consiglio di censura in materia politica non teneva conto della quantità di scritti, specie di periodici e quotidiani, prodotti senza sosta in tutta la penisola.
La riforma di Pio IX: le mani sui giornali
Agli inizi del 1846, il carico di lavoro eccessivo e l’impossibilità di controllare in modo capillare “le tanta copie generate dalle produzioni dei tempi ed in cui direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, si viene a parlare di cose che si riferiscono alla politica”23 spinsero lo Stato Pontificio, sotto la guida del neo pontefice Pio IX, ad operare una profonda riforma nel campo della censura ecclesiastica, specie grazie alla costituzione di centri di censura satellite a carattere non più individuale ma collegiale.
Gli istituti, emanazione della sovranità della Santa Sede, avrebbero svolto una attività tale da esplicare i suoi effetti su tutto il territorio regio.
Al moltiplicarsi dei poli di controllo corrisponde una moltiplicazione dei giornali e dei periodici che, prima di allora, non avrebbero potuto circolare copiosi nel paese se non in modo illegale24. E questo, proprio perché non era ammessa la pubblicazione se non previo esame degli scritti.
Nonostante tale effetto perverso, la riforma ebbe comunque una eco importante in tutta la penisola poiché previde, per la prima volta nella storia della censura ecclesiastica, una serie di garanzie per favore della libertà di stampa.
Garanzie che avrebbero influenzato molto il contenuto della legge speciale sulla stampa di Carlo Alberto e, ancor prima, la legge di stampo liberale che nell’autunno del 1847 avrebbe allentato la morse della censura preventiva piemontese.
L’editto del 12 marzo 1847, promulgato dallo Stato Pontificio sotto Pio IX, regola la libertà di stampa e il giornalismo istituendo i Consigli di Censura e le regole che i censori avrebbero dovuto osservare, inclusi i criteri da adottare nella valutazione degli scritti e le regole per il coordinamento dei diversi uffici su tutto il territorio rispetto alla Segreteria di Stato vaticana.
Il neo-eletto pontefice viene salutato dall’opinione pubblica come una promessa di liberalità, colui che potrà indirizzare favorevolmente il dibattito sul costituzionalismo moderato25. E a dispetto dell’oggetto della legge, quel documento inaugurerà una breve stagione di apertura per l’editoria romana26.
L’editto però si preoccupa di controllare in modo capillare la stampa di giornali e di periodici. Il perché di una tale scelta è presto detto: a preoccupare Roma non è solo la circolazione di opere di singoli scrittori, ma la diffusione di ideologie e dottrine eterodosse attraverso uno strumento, il giornale, che conosce ritmi di pubblicazione ben più accelerati rispetto a quelli di un libro27.
E’ l’inizio dello scontro più aspro tra censori civili e censori ecclesiastici. Ma anche dello scontro più acceso di sempre tra censura e giornali da un lato e censura ed editori dall’altro. Anzi, ce n’è uno in particolare, milanese di nascita ma approdato a Torino nel 1844, Francesco Predari, che ne avrà da ridire sulla doppia censura… (ma lo vedremo nel prossimo numero)
Su questo punto e per una ricostruzione completa della censura ecclesiastica dai secoli XVI a XIX si veda il saggio di HUBERT WOLF, Storia dell’Indice – il Vaticano e i libri proibiti, Donzelli, Roma, 2006. Per la diversa declinazione del concetto di censura nell’Illuminismo, periodo in cui la diffusione di tali idee si è dovuta scontrare molto con la censura, cfr. SERGIO MORAVIA, Il tramonto dell'Illuminismo: Filosofia e politica nella società francese. (1770-1810), Roma, 1968; ANTONIO SANTUCCI, Interpretazioni dell’Illuminismo, Bologna, 1979. Per la ricostruzione dell’iter normativo della censura dal 1846 ai giorni nostri si rimanda a GIOVANNI PONZO, Le origini dell libertà di stampa in Italia, 1846 – 1983, Milano, 1980
Atti del Consiglio di Conferenza, sedute del 3 e 7 febbraio 1848, in NEGRI-SIMONE., op. cit. nella newsletter Lezioni di censura n.1 | Il veleno e l’antidoto.
Per una disamina sulle classificazioni giuridiche della libertà di manifestazione del pensiero si rimanda a SERGIO FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero; in senso contrario a una rigida classificazione e suddivisione delle libertà fondamentali VIRGA P., Libertà giuridica e diritti fondamentali, Milano, 1950.
Nella visione di Wolf, “il fenomeno della censura è più antico della scrittura stessa”.
Si tratta del celebre testo politico di Vincenzo Gioberti sul “primato civile e morale degli italiani”, propugnante un’indipendenza italiana costruita sulle basi dello stato pontificio e dell’autorità papale. La posizione varrà a Gioberti il titolo di “neo-guelfo” e numerosi attacchi da parte del Rosmini. Per le fonti si veda VINCENZO GIOBERTI, Del primato civile e morale degli italiani, Napoli, 1848, I ed., riproduzione digitale Harvard University Library, 2008, p. 86
E’ quanto emerge sia dallo studio del Ponzo, op. cit., che da quello di GIORGIO LAZZARO, La libertà di stampa in Italia dall’Editto albertino alle norme vigenti, Milano, 1969.
La commistione, in tale contesto, è documentata dall’aspra polemica condotta da un giovane Marx contro la riforma della censura in Prussia agli inizi dell’Ottocento, criticata proprio per confondere misure preventive e misure repressive a scapito della libertà di stampa. In tal senso cfr. il saggio di PAOLO NAPOLI, Misura di polizia - Una prospettiva storico-concettuale in età moderna, Quaderni Storici, 2009. Gli articoli di Marx sono contenuti in LUIGI FIRPO, Scritti politici giovanili/ Karl Marx, Torino, 1950.
In tal senso cfr. sempre LAZZARO, op. cit, e WOLF, op. cit.
Alcuni dei contributi documentali sulla stampa sono reperibili nel Magnum Bullarium Romanum, in particolare la bolla Sollicita ac Provvida, s.2 Benedicti Papae XIV Bullarium, t. IV. Roma, 1757, rist., Graz 1966, pp. 115-24, in Wolf, in nota 1, op. cit. p.39
Ad esempio, le norme sulla stampa contenute nella costituzione del Regno delle Due Sicilie dell’11 febbraio 1848 e l’editto ad hoc del Granducato di Toscana ravvisano elementi di forte similitudine con l’editto di Pio IX del 12 marzo 1847. I testi delle costituzioni e degli editti in questione sono reperibili in GIUSEPPE LA FARINA, Storia d'Italia dal 1815 al 1850 , II ed., Torino, 1860, ripr. digitale Oxford University Library, 2007, pp. 322 e ss.
Così MARIA IOLANDA PALAZZOLO, Editoria e istituzioni a Roma tra Settecento e Ottocento, in Roma Moderna e Contemporanea – Quaderni, 1994, Roma, pp. 32 e ss.
Sulla classificazione della censura come strumento di ordine pubblico esiste una vasta bibliografia, fra cui si rimanda a HUBERT WOLF, op. cit., e PAOLO NAPOLI, Naissance de la Police Moderne, Pouvoirs, normes, société, La Découverte, Parigi, 2003
Vedi opera di Wolf citata nelle note precedenti.
Nonostante il carattere repressivo – ovvero principalmente sanzionatorio - l’Editto sulla stampa presentava elementi di rottura con la disciplina anteriore all’adozione della carta costituzionale e pur mantenendo delle macroscopiche misure in senso preventivo, poteva comunque essere annoverato tra le leggi di stampo liberale dell’epoca. E per “epoca” deve intendersi un periodo in cui la struttura sociale e giuridica del Piemonte era fortemente aristocratica e militarizzata. In questo senso cfr. GIORGIO LAZZARO, op. cit.
Il che non implica necessariamente una diversità sostanziale della disciplina. Il controllo poteva essere esercitato da soggetti diversi – amministrazione statale, giudice ad hoc, commissione ministeriale, curia, censore ecclesiastico, ecc… ecc.. – e con criteri diversificati, ma che non avrebbero potuto mutare radicalmente. Specie grazie alla vicinanza e alle influenze che gli ordinamenti italiani esercitavano reciprocamente gli uni sugli altri.
Diversi Stati italiani rimettevano le funzioni di censura ad apparati già esistenti, ad esempio tribunali ordinari o prefetti locali. Nel Regno di Sardegna esisteva una Commissione di Revisione dei libri e delle stampe con specifici compiti e di cui tuttavia Carlo Alberto desiderava una riforma sulla falsariga di quanto verrà introdotto dall’editto di Pio IX nel 1847.
Si tratta delle riforme introdotte da Pio IX il 12 marzo 1847 e anticipate da una circolare del 1846
Una versione integrale del documento è disponibile nella Raccolta delle leggi e disposizioni di Pubblica Amministrazione Stato Pontificio sotto Leone XII, Roma, 1850. Si tratta dell’Editto del 18 agosto 1825.
Dall’ Editto del 12 marzo 1847, in ANTONIO MONTANARI, La legge sulla stampa del 15 marzo e la circolare del 19 aprile del 1847 emanate in nome del pontefice Pio nono dal cardinale Gizzi, segretario di stato: commenti, Bologna, 1847, ed. digitale University of California, 2007, p. 6 ed. digitale (3 ed. originale). Si tratta del celebre Editto sulla stampa del 12 marzo 1847 emanato, per conto di Pio IX, dal Cardinal Gizzi, entrato in vigore il 15 marzo e di cui si è accennato nella prima parte. Il preambolo ripercorre le ragioni che spingono il Pontefice a riformare le disposizioni di Leone XII che verranno solo in parte modificate - e tale modifica sarà proprio oggetto di aspre critiche da parte delle frange più progressiste che, a differenza delle componenti costituzionali moderate, non saluteranno il provvedimento come legge liberale.
Il rapporto tra misura di polizia e censura è oggetto di una analisi separata, già affrontata in tal senso nel saggio di NAPOLI, Naissance de la Police Moderne, op. cit. nota 46, a cui si rimanda. Inoltre, l’editto di Pio IX verrà emanato quale tassello di una riforma più estesa che toccherà anche il sistema di polizia degli Stati Romani introducendo la Guardia Civica con un Editto del 5 luglio 1847, n° 59 recante “Norme fondamentali approvate dalla Santità di Nostro Signore per l’adempimento della decretata ricostituzione ed ampliazione della guardia civica di Roma”, in Raccolta delle leggi e disposizioni di Pubblica Amministrazione Stato Pontificio emanate nel pontificato della santità di Nostro Signore Papa Pio IX, vol. I, Roma 1849, ripr. digitale Library of Princeton University, 2008.
Si dovrà attendere il 1815 per una effettiva applicazione dei criteri adottati nella bolla Sollicita ac provvida del 1753. Cfr. Wolf, op. cit.
Così Wolf, p. 43 in op. cit.
Editto del 12 marzo 1847, Pio IX, in ANTONIO MONTANARI, op. cit.
Questa improvvisa impennata delle pubblicazioni potrebbe anche essere dovuta ad una semplice emersione di gran parte della produzione editoriale sommersa, prima di adesso non sottoposta ad un controllo così capillare. E’ quanto emerge dai dati dell’epoca, pubblicati in particolare da FRANCESCO LAMPATO, Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio, Milano, 1848, vol XV, ripr. digitale Harvard University Library, 2007
Cfr. GIACOMO MARTINA, op. cit.
Così la PALAZZOLO, op. cit., Introduzione.
Sempre nell’Editto del 1847 il Cardinal Gizzi descrive ampliamente “gli abusi di quest’arte mobilissima”, in Preambolo alla legge sulla stampa di Pio IX, op. cit.